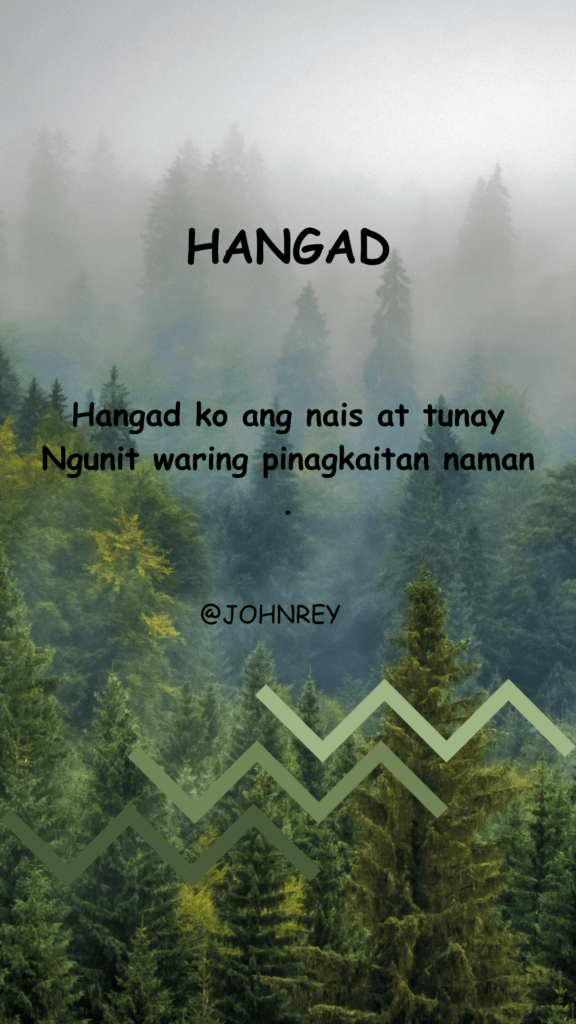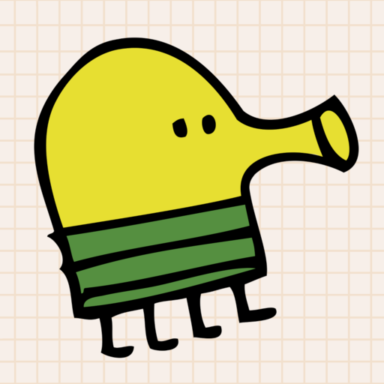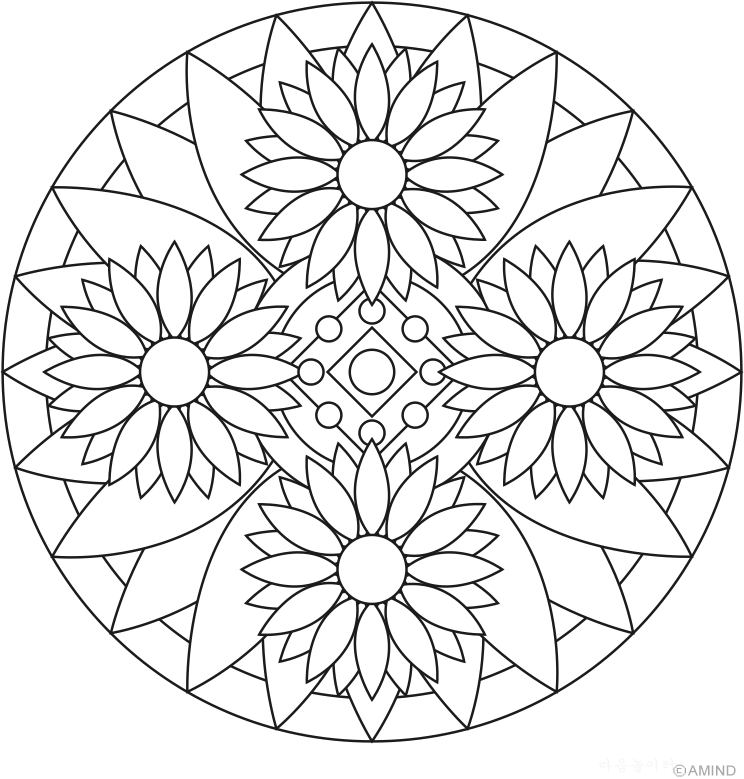Sono già passati cinque anni dalla morte di David Foster Wallace. Pubblichiamo un’intervista del 1993 tratta da Un antidoto contro la solitudine e tradotta da Martina Testa. Aggiungiamo che ci manca moltissimo.
(Foto: Giovanni Giovannetti/Effigie)
In cerca di una «guardia» a cui fare da «avanguardia». Un’intervista con David Foster Wallace di Hugh Kennedy e Geoffrey Polk (1993)
A trent’anni, David Foster Wallace è stato definito il migliore rappresentante della sua generazione di scrittori americani. Grazie al romanzo La scopa del sistema e alla raccolta di racconti La ragazza dai capelli strani si è conquistato ampi consensi da parte della critica, un prestigioso Whiting Writers’ Award e un pubblico di lettori intensamente devoto. Wallace, laureato in matematica e filosofia all’Amherst College, ha cominciato a scrivere solo all’età di ventun anni. Il suo primo romanzo è stato pubblicato mentre ancora frequentava un master presso l’Università dell’Arizona, a Tucson. La sua scrittura è arricchita da una comprensione matematica e filosofica dei sistemi simbolici e dei concetti estesi, onnicomprensivi, che portano ogni idea alla sua estrema e spesso più esilarante conseguenza. È inventivo in un modo che ricorda Pynchon, e culturalmente onnivoro in un modo che ricorda chiunque da Don DeLillo a David Letterman, che è anche il protagonista di uno dei suoi racconti.
Alla Cleveland State University, Wallace ha letto passi del suo secondo romanzo a una vasta platea che ha mostrato di gradire molto. Spera di finire questo romanzo entro un anno dal trasloco nella sua nuova casa di Syracuse, nello stato di New York. Abbiamo incontrato David Wallace nella sua suite in un albergo al centro di Cleveland, il giorno dopo il reading. Portava un maglione a righe a collo alto, pantaloni grigi e un paio di pesanti scarponi marroncino chiaro. Durante la prima metà dell’intervista, Wallace ha masticato e sputato tabacco Kodiak in un piccolo secchiello bianco, con una gamba appoggiata sulla poltrona oro e viola; per la seconda metà ha fumato e bevuto Diet Coke. Portava i capelli castani con la riga in mezzo, il che lo costringeva a scansarseli spesso da davanti agli occhi, e aveva l’abitudine di darsi leggeri colpetti dietro la testa con la mano aperta, gesto che, ha commentato Wallace, discende direttamente da suo padre, insegnante di filosofia presso l’Università dell’Illinois di Urbana-Champaign, passando per l’insegnante del padre, Norman Malcolm, l’ultimo allievo di Wittgenstein, per risalire a Wittgenstein in persona. Wallace parlava in una voce morbida e sommessa con l’accento del Midwest.
La sua naturale timidezza, unita alla straordinaria intelligenza, può farlo apparire un po’ scostante, e ha confessato che nella sua famiglia si comunica soprattutto tramite battute di spirito e risposte argute. Ha anche osservato che «due anni fa, non avrei mai fatto una cosa del genere. Non mi sarei mai seduto a parlare davanti a due persone che non conoscevo bene. Non ce l’avrei fatta. Mi sarei chiuso in bagno e avrei strillato le risposte da dietro la porta». Una volta che si è rilassato, però, è diventato generoso e sincero e ha esposto in grande dettaglio – e perfino con passione – i suoi giudizi e le sue idee sulla letteratura.
(H.K.)
H.K.: Ho trovato interessante il modo in cui hai usato la filosofia come elemento del tuo primo romanzo, La scopa del sistema, e mi sono chiesto se a un certo punto avessi dovuto decidere se scrivere o meno di filosofia come fanno normalmente i filosofi, e poi magari ti fossi reso conto che la letteratura poteva essere un modo, a livello culturale, di mettere insieme concetti come la filosofia, Dio, l’America e via dicendo.
Wallace: Non so voi, ma io ho cominciato a scrivere narrativa solo a ventun anni, e all’inizio tutti dobbiamo necessariamente scrivere una certa quantità di puttanate, e le mie puttanate erano, in buona sostanza, saggi sotto mentite spoglie. Erano una specie di Ayn Rand rifatta molto male, qualcosa del genere. All’università ho studiato matematica e filosofia. Non ero uno scrittore, quindi c’entra molto il fatto che La scopa del sistema, nella sua prima stesura, sia stata una delle mie due tesi di laurea. L’altra era una cosa complicatissima di matematica e semantica che pescava da Wittgenstein a piene mani. E questi due testi continuavano a contaminarsi fra loro: la tesi di matematica, per dire, era scritta in tono discorsivo, come in teoria non si dovrebbe fare. Insomma, c’era un continuo interscambio fra le due cose. L’altro fattore è che mio padre è un filosofo di professione, è stato allievo dell’ultimo allievo di Wittgenstein, Norman Malcolm, che ha anche scritto la sua biografia. Tante parti della Scopa del sistema sono stranamente autobiografiche, per aspetti che, a parte me, nessuno può capire. Per dire, il titolo viene dal modo in cui mia madre chiama la crusca. Lei chiama la crusca e le fibre «la scopa del sistema». Mi pare che a un certo punto nel libro ci sia un’allusione en passant a questo fatto.
H.K.: Mi sono chiesto se la tua famiglia, come quella di Lenore Beadsman, è «molto verbale» e vede la vita «più o meno come un fenomeno verbale».
Wallace: La prima versione della Scopa del sistema parlava moltissimo della famiglia, e molto di quel materiale è stato eliminato perché non era particolarmente efficace. Però sì, nella mia famiglia funziona molto così. Fra noi comunichiamo quasi soltanto tramite battute di spirito. Fondamentalmente, non facciamo altro che raccontarci barzellette, il che a un certo punto diventa abbastanza strano. È molto divertente quando sei piccolo, ma quando ti ritrovi adulto e cerchi di parlare di qualcosa di serio, ti rendi conto che è un modo un po’ insidioso di affrontare le cose. Il romanzo su cui sto lavorando adesso ha molto a che fare con la famiglia e… è difficile, è difficile provare a cogliere qualcosa che sia reale, è difficile provare a capire quali esperienze familiari sono universali e quali idiosincratiche.
H.K.: Mi piace moltissimo il personaggio di Lenore Beadsman, mi sembra davvero memorabile, in particolare il modo in cui trasmetti la sua voce. Come ci sei arrivato?
Wallace: Ho avuto un sacco di problemi con quel personaggio, perché alla fine del libro mi sono ritrovato innamorato di lei. Ecco uno dei motivi per cui da allora non ho più lavorato su qualcosa di simile. Al momento di staccarmene ero davvero turbato. Lenore è una sorta di collage di tante persone che conosco. Ma probabilmente ha dentro il mio modo di ragionare e il mio modo di parlare, più che quelli di chiunque altro. Direi che all’inizio c’erano solo due voci che sapevo fare bene: una era la sua, l’altra era una voce ipersensibile e veramente intellettuale. Uno dei punti deboli del libro è che tanti dei personaggi sembrano avere la stessa voce: Rick Vigorous parla un po’ come David Bloemker, che a sua volta parla un po’ come Norman Bombardini e perfino come il padre di Lenore. Molto spesso è una parodia della prosa intellettuale.
H.K.: Io ho avuto la tua stessa reazione nei confronti di Lenore. Mi è dispiaciuto tantissimo doverla lasciare.
Wallace: Era veramente un amore.
H.K.: Una domanda su Rick Vigorous. Ho pensato molto alla scena in cui torna ad Amherst dopo vent’anni e fa un giro per il campus, ancora dividendo i ben inseriti dagli emarginati. Mi sono chiesto se pensi che tutti gli scrittori siano in qualche modo degli outsider, rispetto alla società.
Wallace: Non lo so. All’università mi sentivo molto solo. La parte del libro che mi piace e che suona autentica è quella roba lì, che per me era vera. Era così che mi sentivo. Gli scrittori che conosco hanno una certa autoconsapevolezza, una capacità di lettura critica di sé e degli altri che li aiuta nel loro lavoro. Ma quel tipo di sensibilità rende molto difficile stare in mezzo alla gente senza ritrovarsi per così dire a levitare dalle parti del soffitto, guardando quello che succede. Una delle cose che voi due scoprirete, una volta usciti dall’università, è che riuscire a vivere davvero come un essere umano, e contemporaneamente a produrre qualcosa di valido, con quel grado di ossessività che è necessario per farlo, è veramente complicato. Non è un caso che si vedano tanti scrittori entrare nel trip della celebrità da popstar, o iniziare a bere e drogarsi, o rovinarsi il matrimonio. Oppure uscire semplicemente di scena poco dopo i trenta o quarant’anni. È veramente complicato.
G.P.: Probabilmente bisogna fare un sacco di sacrifici.
Wallace: Non so neanche se sia una decisione volontaria o totalmente conscia. Quasi tutti gli scrittori che conosco sono molto concentrati su se stessi, non nel senso che si pavoneggiano davanti allo specchio, ma che hanno una tendenza non solo verso l’introspezione, ma verso una tremenda forma di autoconsapevolezza. Quando scrivi, ti devi continuamente preoccupare dell’effetto che farai sul tuo pubblico. Stai dicendo le cose in maniera troppo sottile, o non abbastanza sottile? Cerchi sempre di comunicare in modo originale, e quindi diventa molto difficile, almeno per me, comunicare come vedo comunicare fra loro i normali abitanti di Cleveland, con le loro guanciotte rosse, quando si incontrano per la strada. La mia risposta, per quanto mi riguarda, sarebbe che no, non è un sacrificio; è semplicemente il mio modo di essere, e credo che non sarei felice a fare qualunque altra cosa. Penso che le persone congenitamente portate per questo tipo di lavoro siano per certi versi dei sapienti, per altri versi quasi dei ritardati. Andate a un convegno di scrittori, una volta o l’altra, e ve ne renderete conto. Si va lì per incontrare autori che sulla carta sono semplicemente straordinari, e di persona sono del tutto disadattati. Non hanno idea di cosa dire o cosa fare. Tutto quello che dicono viene controllato, e in fondo minato, da una specie di editor che hanno dentro. La mia esperienza è stata questa. Perciò negli ultimi due anni ho investito una parte molto maggiore della mia energia a insegnare, cioè di fatto esercitandomi a vivere da essere umano.
H.K.: Per il nostro laboratorio di scrittura abbiamo letto un articolo di Ben Satterfeld che contiene l’ormai tradizionale raffica di sparate un po’ a casaccio contro i corsi di scrittura creativa e il ciclo di mediocrità che vanno a creare. Per tutto il pezzo Satterfeld se la prende con gli insider, con la gente che ha frequentato corsi post-laurea di scrittura, e sostiene invece che bisogna uscire nel mondo e trovare la propria strada da soli, senza tutti questi editor che ti ronzano intorno e tutte queste figure inserite nel mondo editoriale che ti portano alla pubblicazione. Eppure uno dei pochissimi scrittori che Satterfeld nomina specificamente fra quelli che al momento stanno scrivendo cose davvero eccellenti e originali sei tu, e tu esci da un corso di laurea e un master. Non voglio solo sapere qual è la tua reazione a Satterfeld, ma a questo tipo di argomentazione in genere: per te, qual è stata l’utilità di un mfa?[1]
Wallace: Mi piacerebbe aver letto l’articolo. (Ride.) Be’, io non ho avuto un’esperienza molto felice all’università, ma mi sembra che ci siano vari modi di trarne comunque un insegnamento. Si può imparare qualcosa adeguandosi alla linea del partito, per così dire, di un certo corso, oppure si può fare il James Dean della situazione e schierarsi dalla parte opposta. A volte è solo quando hai dei professori – ossia delle figure di autorità – che ti rompono le palle, e ti ritrovi a opporre comunque resistenza alle loro idee, che capisci in cosa credi davvero. È stato interessante venire qui [alla Cleveland State University]. Ho fatto una lunga chiacchierata con Neal Chandler sul vostro corso, e mi sono convinto che siate veramente fortunati. Mi sembra che esistano due tipi di corsi post-laurea di scrittura creativa. Un tipo è quello che mi sembra esista alla Cleveland State, e all’Università di Syracuse, per dire, cioè un master con una focalizzazione sulla scrittura creativa, in cui però ci sono dei veri e propri requisiti accademici. Ti viene richiesto di imparare a scrivere nell’ambito di una più ampia formazione nelle discipline umanistiche. E questo tipo di corsi, lo so che non li ho mai seguiti personalmente, ma dall’esterno mi sembrano fantastici.
Uno dei miei più grossi problemi all’Università dell’Arizona è stato che anche se mi piacevano molto gli studenti, e mi piacevano molto parecchi dei professori normali, non mi piacevano particolarmente gli insegnanti di scrittura creativa. Disprezzavano davvero l’idea che imparare a scrivere significasse anche imparare a entrare a far parte della tradizione letteraria occidentale. All’Università dell’Arizona ho seguito un sacco di corsi esterni – ho studiato un sacco di teoria, un po’ di matematica, un po’ di lingue straniere, un po’ di storia della lingua – e i responsabili del corso di scrittura creativa mi prendevano per matto. Posti come l’Università dell’Arizona, l’Università dell’Iowa o Stanford secondo me fingono soltanto di essere delle scuole.
Non voglio dirne peste e corna, ma penso che sia necessario fare una distinzione fra università come quelle e università come la Cleveland State e Syracuse, che sono veramente istituzioni didattiche, da cui si esce con un master. Le fabbriche di mfa sono, di fatto, forme velate di assistenzialismo. Ai docenti, in genere, offrono la comodità e la sicurezza di un impiego vita natural durante. Tenere un laboratorio di scrittura, anche se a suo modo richiede impegno, non è paragonabile a preparare lezioni sulla storia della matematica tre volte a settimana. Non è proprio paragonabile. E dato che gli scrittori sono costituzionalmente pigri per la maggior parte delle cose al di fuori della loro scrittura, anche questo aspetto li incoraggia. Ma i corsi di quel tipo sono anche forme di assistenzialismo per gli studenti, perché un tempo succedeva che uscivi dall’università, ti trovavi un lavoro di merda, andavi a vivere in un loft di Soho e cercavi di fare lo scrittore. E il signor Satterfeld può trovarci anche un certo elemento di romanticismo. Conosco gente che ha fatto quel percorso, ed è assolutamente devastante, è tremendo.
Per dire, anch’io ho sfiorato quel genere di vita da quando ho finito il master, e sono stato fortunato perché ho pubblicato un paio di libri. Le mie cose trovano un editore più facilmente, rispetto agli autori che devono spedire il manoscritto alla cieca, ed è comunque una situazione pesante. Non è divertente. Ma se frequenti uno di quei corsi, ai tuoi genitori e a chiunque ti chieda: «Cosa stai facendo?» puoi rispondere: «Be’, sto facendo un master». E la gente ti lascia in pace. Molto spesso ricevi anche forme di assistenza finanziaria. Vere e proprie borse di studio, come quella che avevo io all’Università dell’Arizona, oppure l’opportunità di insegnare, e di mantenerti in quel modo. Certo, gli allievi vengono un po’ sfruttati, ma è comunque molto meglio che lavorare alla cassa di un fast food. È mille volte meglio.
H.K.: Che effetto vorresti che facesse la tua scrittura?
Wallace: Vuoi una risposta onesta, giusto?
H.K.: Nei limiti del possibile.
Wallace: È molto difficile separare l’effetto che vuoi che faccia la tua scrittura dall’apprezzamento che vuoi ricevere per quello che scrivi. Alle tre di notte, quando sono solo con me stesso, fantastico di parate ufficiali in mio onore, Poeta Laureato dell’Occidente, borse di studio MacArthur e premi Nobel, reading come quello di ieri sera ma davanti a un pubblico di quindicimila persone, roba così, insomma. Questo per dire che i pensieri riguardo all’effetto desiderato non sono mai puri, mai privi di fini egoistici. Però ci sono parecchi libri che dopo averli letti mi hanno lasciato per sempre diverso da com’ero prima, e penso che tutta la buona letteratura in qualche modo affronti il problema della solitudine e agisca come suo lenitivo. Siamo tutti tremendamente, tremendamente soli. Ma c’è qualcosa, quantomeno nei romanzi e nei racconti, che ti permette di entrare in intimità con il mondo, e con un’altra mente, e con certi personaggi, in un modo in cui non puoi proprio farlo nel mondo reale. Io non so cosa stai pensando. Non so molto di te, così come non so molto dei miei genitori, della mia ragazza o di mia sorella, però un brano di letteratura che sia davvero sincero ci permette di entrare in intimità con… non voglio dire con la gente, ma ci permette di entrare in intimità con un mondo che assomiglia al nostro quanto basta, a livello di dettagli emotivi, perché le varie sensazioni che proviamo possano poi riverberarsi anche nel mondo reale. L’effetto che vorrei che avesse quello che scrivo è far sentire le persone meno sole. O insomma, toccare le persone in qualche modo.
Mi sa che a volte quando scrivo, se cerco di essere particolarmente offensivo, scandaloso e via dicendo, in realtà ho solo il desiderio vorace di provocare un qualche tipo di effetto. Secondo me in American Psycho si vede che Bret Ellis sta facendo questo. Non puoi assicurarti che a tutti piaccia quello che scrivi, ma cazzo, se hai un po’ di tecnica, puoi assicurarti che il lettore non resti indifferente. Un sacco di scrittori smaniano per far circolare di più le proprie opere e vendere più copie, e un tempo credevo che fosse volgare materialismo, che volessero i soldi, ma in realtà quello che uno vuole è provocare un qualche effetto. Magari voi l’avete già capito. Ma a me sono serviti anni per rendermene conto.
G.P.: In La ragazza dai capelli strani, molti racconti vanno al di là delle semplici storie personali e arrivano a toccare temi generazionali. Ad esempio, «Lyndon» in molti punti sembra osservare le differenze fra generazioni: per dirne una, le idee di Lyndon sulla responsabilità e su ciò che implica, contrapposte alla generazione degli anni Sessanta. In «Verso Occidente l’Impero dirige il suo corso», fra J.D. Steelritter e i ragazzi c’è un conflitto dello stesso tipo, stavolta sull’idea di onore, che alla fine Mark Nechtr ammette di condividere: eppure è veramente una virtù d’altri tempi. E «La ragazza dai capelli strani» l’ho visto come un commento non solo sul conservatorismo reaganiano e gli effetti delle sue politiche – vale a dire una sorta di sadismo – ma anche sulla generazione punk degli anni Ottanta, che di ideali politici non ne ha nessuno. Insomma, nelle tue storie continuo a trovare questi temi generazionali. Sei d’accordo?
Wallace: Sta diventando un po’ difficile da ricordare. Quel libro l’ho finito nell’88, e poi c’è stato un anno di battaglie legali prima che venisse pubblicato, quindi mi sembra un sacco di tempo fa. Forse l’ho già detto anche ieri sera, ma al master ho conosciuto un sacco di gente, un sacco di poeti, in particolare, un po’ più grandi di me, veri adoratori degli anni Sessanta, secondo cui il nostro problema era che avevamo perso molta dell’integrità ribelle e sincera degli anni Sessanta. Io in realtà vedo la nostra generazione come erede degli anni Sessanta. E intendo specialmente dal punto di vista artistico, perché negli anni Sessanta si sono abbandonate molte tecniche convenzionali in favore dell’umorismo nero e di una nuova enfasi sull’ironia. Non si vedeva un’ironia del genere, di fatto, da prima del romanticismo. L’ironia ha svolto una funzione molto utile, facendo piazza pulita di un sacco di luoghi comuni e falsi miti, nella cultura americana, che non servivano più a nulla; ma purtroppo non ci ha lasciato niente da cui ricominciare a costruire, se non un atteggiamento di sufficienza sarcastica, di nichilismo autoreferenziale e di avidità materiale.
Uno dei motivi per cui in questo libro ho parlato tanto della tv è che adesso molto dell’atteggiamento ribelle degli anni Sessanta lo vediamo nella produzione televisiva: roba che all’epoca rappresentava il gesto artistico, l’autoreferenzialità, la metanarratività. Adesso si vede l’ultima puntata di Moonlighting che finisce con le scenografie smantellate. La tendenza originaria verso l’ironia e l’autoreferenzialità che negli anni Sessanta era il modo in cui i giovani si proteggevano dall’ipocrisia famelica di istituzioni come il governo e la pubblicità ora si è insinuata nella cultura popolare, e dato che si è insinuata nella cultura popolare, la cultura popolare stessa è diventata enormemente più efficace e più pervasiva nella vita degli americani. Cioè: la tv oggi è talmente bella. mtv ti ipnotizza proprio. E quindi ci sono i giovani della mia generazione, fra i venti e i trentacinque anni, ancora un po’ in bilico, mentre tutti i ragazzi più piccoli di noi vengono letteralmente risucchiati dentro quel mondo, e lo imparano in un modo che non gli permette di esercitare nessun tipo di incredulità.
Comunque sia: una delle cose che volevo fare, con La ragazza dai capelli strani, era scrivere un tradizionalissimo libro con una morale. La mia è una generazione che non ha ereditato assolutamente nulla, in termini di valori morali significativi, ed è nostro compito crearceli, e invece non lo stiamo facendo. E ci viene detto, dagli stessi sistemi di cui gli anni Sessanta facevano benissimo ad avere paura, che non dobbiamo preoccuparci di inventare sistemi morali: insomma, che il senso della vita sta tutto nell’essere belli, fare tanto sesso e possedere un sacco di cose. Ma il risvolto sinistramente delizioso è che i sistemi che ci dicono questo stanno usando le stesse tecniche che avevano usato gli autori degli anni Sessanta: ossia tecniche postmoderne come l’ironia nera, le involuzioni metanarrative, tutta quella specie di letteratura dell’autoreferenzialità. Noi ne siamo gli eredi. E direi che la penso ancora nello stesso modo. Sto ancora scrivendo di persone giovani che cercano di trovare se stesse dovendosela vedere non solo con dei genitori che gli impongono di conformarsi, ma anche con lo scintillante e seducente sistema elettromagnetico tutto attorno a loro che gli dice che non ce n’è bisogno. Non so se mi spiego.
G.P.: Ti convince la risposta di John Gardner, cioè affermare nella scrittura la bellezza della vita? L’altra sera (al reading), mi è sembrato che provassi un’empatia con i tuoi personaggi che ti colloca al di là della satira.
Wallace: Be’, Gardner non sta dicendo niente che non dicesse già Tolstoj, solo che Tolstoj lo diceva nella sua maniera stramba da fondamentalista cristiano ortodosso russo. Per Tolstoj lo scopo dell’arte era comunicare l’idea della fratellanza cristiana da un uomo all’altro e trasmettere un qualche tipo di messaggio. A me pare che Gardner traduca questa idea in una sorta di didatticismo morale. E credo che sottovaluti quelle che sono le reali possibilità dell’arte. Ma hanno ragione tutti e due: ciò che fanno la narrativa e la poesia è ciò che stanno cercando di fare da duemila anni a questa parte, ossia toccare il lettore, fargli provare certe sensazioni, permettergli di instaurare un rapporto con delle idee e dei personaggi che sarebbe impossibile nell’ambito di un normale scambio verbale tipo quello che stiamo avendo in questo momento: tu non vedi me, io non vedo te. Ma ogni due o tre generazioni il mondo diventa enormemente diverso, e diventa enormemente diverso il contesto in cui si deve imparare a vivere da esseri umani, o ad avere buoni rapporti con gli altri, o a decidere se Dio esiste o meno, o se l’amore esiste, e se può redimere la gente. E le strutture grazie alle quali si possono comunicare questi dilemmi o farli affrontare dai personaggi sembra che a un certo punto diventino inadeguate, e poi di nuovo adeguate, e così via. Ma niente di quello che è cambiato ai nostri giorni mi sembra di importanza fondamentale, anche se tante cose sono molto, molto diverse. Quindi sì, direi che sono d’accordo con Gardner nella misura in cui ha il buon senso di ripetere la lezione di Tolstoj – tolta la parte trascendente cristiana. Sono l’unico scrittore «postmoderno» al mondo che ha una venerazione assoluta per Tolstoj.
G.P.: Nei tuoi racconti, giochi spesso con i confini fra la storia e la finzione. Ti fa un effetto strano appropriarti di figure realmente esistite?
Wallace: Ha delle ripercussioni legali. La prima versione del racconto su Letterman («La mia apparizione») doveva uscire su Playboy ed era molto diversa. Conteneva delle vere e proprie trascrizioni di un’intervista di Letterman a Susan Saint James. Come un coglione non l’ho detto ai redattori della rivista, e un paio di settimane prima di quando era prevista l’uscita del racconto, in tv hanno passato una replica proprio di quell’intervista; nella redazione di Playboy se ne sono accorti, e mi hanno fatto un culo così. E in tutte le altre riviste che avevano pubblicato dei miei racconti gli avvocati sono andati totalmente nel panico, e ci è mancato poco che il libro non uscisse più. Quindi ci sono problemi in questo senso. Per quanto riguarda l’uso massiccio della cultura pop, uno dei grossi cambiamenti che ci sono stati è che un tempo la letteratura era una specie di racconto di viaggio. Era un modo per portare la gente in terre straniere e a contatto con culture esotiche, o in mezzo a personaggi importanti, e dare al lettore accesso a mondi a cui non aveva accesso.
Il mondo in cui viviamo oggi è molto diverso. Posso alzarmi la mattina e guardare le immagini via satellite di una rivolta a Pechino mentre faccio una colazione tex-mex ascoltando musica africana sul mio lettore cd. In passato il compito della letteratura era rendere familiare ciò che era strano, portarti in un posto e fartelo apparire familiare. Ma mi sembra che una caratteristica della vita di oggi sia che tutto si presenta come familiare, quindi una delle cose che l’artista deve fare è prendere molta di questa familiarità e ricordare alla gente che è strana. Quindi prendere le immagini più banali, artisticamente più insignificanti, dalla tv, dalla politica e dalla pubblicità, e trasfigurarle… Ok, è un gesto artistico un po’ radicale, ma credo che abbia una sua validità. Penso che se uno riesce a far diventare straniante questa roba, se riesce a far sì che la gente guardi, per dire, un quiz televisivo come Jeopardy! o uno spot pubblicitario e non lo veda come un messaggio divino sceso dal cielo ma come un’opera d’arte, un prodotto dell’immaginazione umana e degli sforzi umani con un obiettivo umano, quello è un modo per distanziare il lettore da certi fenomeni da cui secondo me c’è bisogno che venga distanziato. Ovviamente, non è che tutto questo processo lo fai in maniera consapevole mentre scrivi. Ma è una delle difese che ho trovato per quando mi vengono poste questo tipo di domande, e mi sembra un’argomentazione valida.
G.P.: Ci sono degli scrittori viventi che ti esaltano veramente?
Wallace: Sono un grandissimo fan di Don DeLillo, anche se mi sembra che il suo ultimo libro sia uno dei peggiori. Il DeLillo di Americana, End Zone, Great Jones Street, I nomi e Libra, quello lo amo. Magari L’arcobaleno della gravità come singolo libro è più bello, ma se guardiamo alla produzione complessiva non mi viene in mente nessun altro scrittore appartenente a questa tradizione, da Nabokov in poi, che abbia fatto meglio di DeLillo. Mi piace Bellow, e mi piace molto il primo John Updike: Festa all’ospizio, Nella fattoria, Il centauro, proprio per la pura e semplice bellezza della scrittura, cazzo. E poi vari scrittori latinoamericani: Julio Cortázar, Manuel Puig, tutti e due morti di recente. Ci sono quei giovani scrittori di oggi di cui stavo parlando prima, tipo Mark Leyner, William T. Vollmann, che quest’anno ha quattro libri in uscita; Jon Franzen, Susan Daitch, Amy Homes. Il libro più bello che ho letto ultimamente è della moglie di Paul Auster, che si chiama Siri Hustvedt. Viene da una famiglia norvegese del Minnesota, e ha scritto un libro intitolato La benda sugli occhi. Non si può dire che sia una lettura spassosa, però mamma mia che libro geniale. È il miglior esempio di postmodernismo femminista che abbia mai letto. Fa sfigurare Kathy Acker, per quanto è scritto bene. Non so se ci sono veramente dei giganti che sovrastano tutti gli altri. Penso che certe cose di Pynchon, certe cose di Bellow, certe cose della Ozick verranno ancora lette fra cento anni; forse anche DeLillo.
G.P.: Hai una raccomandazione da fare ai giovani scrittori?
Wallace: Mandatemi almeno il cinquanta per cento di tutto quello che guadagnate.
G.P.: Non basterebbe neanche a coprire il costo del francobollo!
Wallace: È un lungo viaggio. Scrivere è un lungo viaggio. Spero che tutto quello che ho scritto finora non sia neanche lontanamente la roba migliore che posso scrivere. Speriamo di non arrivare a cinquantacinque anni rifacendo sempre la stessa cosa. Bisogna evitare di bruciarsi, diciamo. Ci si può bruciare dibattendosi per tanti anni nella miseria senza nessun riconoscimento, ma ci si può anche bruciare se si riceve un po’ di attenzione. La gente viene a trovarti in albergo e pensa che tu abbia cose interessanti da dire. E allora puoi permetterti di cominciare a pensare che tutto quello che dici è interessante. Per me, il cinquanta per cento delle cose che scrivo sono brutte, punto, e sarà sempre così, e se non sono capace di accettarlo vuol dire che non sono tagliato per questo mestiere. Il trucco è capire quali sono i tuoi difetti e fare in modo che il lettore non li veda.
(Pubblicato originariamente su Whiskey Island, primavera 1993. © Whiskey Island Magazine, 1993. Traduzione di Martina Testa.)
Copyright minimum fax 2013